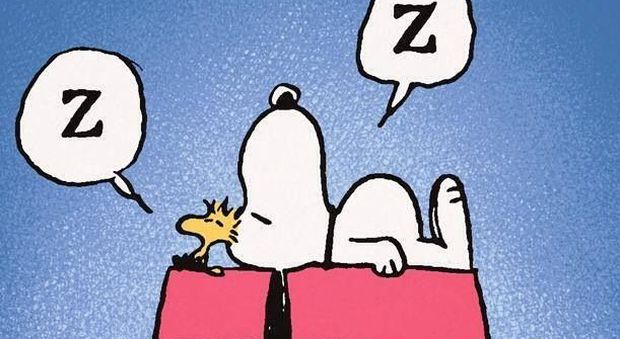
Come abbiamo visto nel precedente articolo su “Sonno e cervello” che trovi qui, dormire è un bisogno essenziale, come mangiare, bere e respirare. Il sonno, infatti, risponde a una serie di necessità fisiologiche, endocrine e psicologiche. Tuttavia, il sonno e i sogni che lo accompagnano sono tra gli aspetti più misteriosi e ancora poco compresi delle neuroscienze.
Il primo ad interessarsi da un punto di vista scientifico alla funzione del sonno e ai sogni è stato certamente Sigmund Freud, il quale sosteneva che i sogni fossero espressione dei desideri inconsci e che potessero essere utilizzati per accedere alla parte più nascosta e remota della mente di un individuo, il suo inconscio.
Oggi, grazie alle tecniche che ci permettono di registrare l’attività cerebrale durante la veglia e il sonno, come l’elettroencefalogramma (EEG)1, è stato possibile approfondire cosa avviene effettivamente mentre dormiamo e sognamo e sono state formulate diverse ipotesi sulle funzioni del sonno.
L’analisi funzionale del sonno distingue quanto avviene nelle fasi di sonno senza movimenti oculari (non-Rapid Eye Movement, non REM), in cui l’attività cerebrale rallenta, e durante il sonno REM (Rapid Eye Movement), in cui viene prodotta un’attività cerebrale simile a quella della veglia, con onde rapide e desincronizzate.
In particolare, il sonno non REM sembrerebbe deputato ad una funzione ristoratrice dell’organismo, con un’attività di regolazione omeostatica a livello metabolico e termoregolatorio, grazie ad un contemporaneo rallentamento dell’attività neuronale.
Il sonno REM, invece, sarebbe collegato soprattutto alle funzioni cerebrali superiori e la frenetica attività cerebrale, simile alla veglia, servirebbe a confrontare le informazioni e le esperienze accumulate durante il giorno con quelle già presenti in memoria per integrarle. Questa fase, caratterizzata da un aumento della sintesi proteica e dell’attività onirica, sarebbe fondamentale per il consolidamento della memoria, l’apprendimento e la maturazione e rigenerazione corticale, attraverso processi di sinaptogenesi, oltre che per far “recuperare energie” al cervello dopo l’attività giornaliera.
Il ruolo dei sogni

In generale, per sogno (dal latino somnium, derivato da “sonno”) si intende quel fenomeno psichico che avviene mentre si dorme, in particolare nella fase REM, caratterizzato dalla percezione di immagini, sensazioni, suoni e/o ricordi riconosciuti come apparentemente reali dal soggetto sognante.
Ne L’interpretazione dei sogni (1900) Freud ipotizzò che, tranne alcune eccezioni, i sogni fossero essenzialmente motivati dalla soddisfazione di un desiderio. Tale desiderio si sarebbe presentato nel sogno sotto forma di un contenuto manifesto simbolico, frutto del lavoro di “censura onirica“, ma avrebbe indicato, al giusto interprete, il contenuto latente sottostante.
Secondo il padre della psicoanalisi, quindi, i sogni sarebbero funzionali al soddisfacimento dei propri bisogni che non possono essere appagati durante la veglia, perché inaccettabili o ignoti all’individuo. Per questo egli definì i sogni la “via regia” dell’inconscio e dedicò ampio spazio alla loro interpretazione nella sua attività clinica.
Sempre grazie all’introduzione delle tecniche di neuroimmagine (come la Risonanza Magnetica Funzionale) e di registrazione dell’attività cerebrale (EEG), è stato possibile distinguere due differenti tipologie di sogno, correlate alle due stadi distinti del sonno:
- durante il sonno non REM, sarebbe presente attività onirica ma più blanda e meno dettagliata, spesso con immagini confuse e sconnesse tra loro, e, al risveglio, è estremamente complicato per il soggetto sognante ricordare cosa stesse sognando nelle diverse fasi di sonno non REM;
- durante il sonno REM, invece, l’attività onirica diventa più complessa e vivida, c’è un filo logico conduttore (seppur surreale) che crea una sorta di narrazione di ciò che sta avvenendo ed il soggetto dormiente, se risvegliato in questa fase, è in grado di riferire fino al 90% di ciò che stava sognando.
Nonostante le nuove conoscenze acquisite sui sogni, una teoria certa e dimostrabile della loro funzione non è ancora stata formulata e resta acceso il dibattito tra chi sostiene che essi contengano significati nascosti, chi ritiene che siano il frutto di segnali cerebrali casuali e chi invece ritiene che abbiano una funzione strategica per il cervello ancora da individuare.
Ciò che sognamo accade veramente nei nostri cervelli.
William Dement
Le teorie sulle funzioni del sonno e dei sogni

Le teorie più recenti in ambito neuroscientifico si focalizzano su aspetti differenti del sonno, ma evidenziano tutte l’importanza del dormire bene:
- Secondo la teoria dell’omeostasi primaria formulata da due neuroscienziati italiani, Giulio Tononi e Chiara Cirelli, il sonno servirebbe al cervello per “tagliare il superfluo”, ovvero per eliminare le nuove connessioni sinaptiche non necessarie che si sono create sui dendriti nel corso della giornata (per un approfondimento su cosa siano le connessioni sinaptiche clicca qui). Ciò sarebbe funzionale ad evitare un eccessivo sovraccarico cognitivo e a garantire di essere pronti a nuove esperienze l’indomani mattina;
- Altri studiosi sostengono la teoria dell’apprendimento secondo cui le fasi REM del sonno stimolerebbero la fissazione dei dati appresi nella memoria a lungo termine. Inoltre, secondo la teoria del recupero, il sonno non REM svolgerebbe una funzione ristoratrice per l’intero organismo, favorendo attività come la produzione di sostanze essenziali o la riprogrammazione genetica;
- Secondo la teoria della “pulizia notturna”, durante il sonno nel cervello si attiverebbe un “sistema di autopulizia” che, sfruttando l’espansione dei canali ventricolari, permetterebbe al liquido cerebrospinale2 di scorrere maggiormente ed eliminare le tossine accumulate di giorno;
- Infine, secondo le cosiddette teorie evolutive, nell’uomo come negli animali, il sonno avrebbe delle funzioni correlate alla conservazione della specie. Ad esempio, permette di preservare energia e “ricaricare le pile” grazie alla riduzione della temperatura corporea e dell’attività metabolica che si verifica soprattutto durante le prime fasi del sonno.
Anche se ancora non vi è certezza rispetto alle funzioni del sonno e dei sogni, di certo le conseguenze della privazione di sonno e di un’elevata sonnolenza diurna sono note e piuttosto dannose sul piano fisico, neuropsicologico e della salute mentale.
NOTE:
1Elettroencefalogramma (EEG): è una tecnica di registrazione dell’attività cerebrale non invasiva, in cui degli elettrodi vengono posti in vari punti del cuoio capelluto per registrare i potenziali elettrici prodotti dalle onde cerebrali, scoperte per la prima volta dallo psichiatra tedesco Hans Berger nel 1920. Storicamente, le regioni del cuoio capelluto sono tipicamente individuate facendo riferimento a una nomenclatura nota come Sistema Internazionale 10-20, in cui le lettere fanno riferimento alle regioni cerebrali (F per Frontale; P per Parietale; T per Temporale; O per Occipitale; e C per Centrale), mentre i numeri indicano la posizione rispetto alla linea mediale, con i numeri pari a destra e i numeri dispari a sinistra (la lettera “z” indica il posizionamento lungo la linea mediana).
2liquido cerebrospinale: anche detto liquor, liquido cefalorachidiano o acqua di roccia, è un liquido trasparente che occupa gli spazi cavi del SNC (ventricoli, spazio subaracnoideo e canale midollare). Esso svolge due principali funzioni: una meccanica, di protezione del SNC dagli urti contro le ossa craniche o la spina dorsale che potrebbero ricevere sia il cervello che il midollo spinale, fungendo da “cuscinetto idraulico”; e l’altra metabolica, legata allo scambio di materiale nutritivo, alla regolazione delle sostanze contenute nell’ambiente interno, alla circolazione sanguigna nel SNC e alla protezione immunitaria.
BIBLIOGRAFIA:
Blundo C, Bruschini M: Il sonno e il sogno. In: Blundo C, Neuroscienze cliniche del comportamento: basi neurobiologiche e neuropsicologiche, psicopatologia funzionale e neuropsichiatria, ed 3, Milano, 2011, Elsevier.
Cionini L: Modelli di psicoterapia, Roma, 2013, Carocci.
Colrain IM. Sleep and the brain. Neuropsychol Rev. 2011;21(1):1-4.
Purves D, Brannon EM, Cabeza R, et al: Principles of Cognitive Neuroscience, 2008, Sinauer Associates, Inc. (trad. it.: Neuroscienze Cognitive, Bologna, 2009, Zanichelli).
Tononi G, Cirelli C. Sleep function and synaptic homeostasis. Sleep Med Rev. 2006;10(1):49-62.
Trošt Bobić T, Šečić A, Zavoreo I, et al. The Impact of Sleep Deprivation on the Brain. Acta Clin Croat. 2016;55(3):469-473.
Zoccoli G: Anatomia funzionale del sistema nervoso. In Maravita A, Fondamenti anatomofisiologici della attività psichica, Milano, 2018, Poletto Editore.
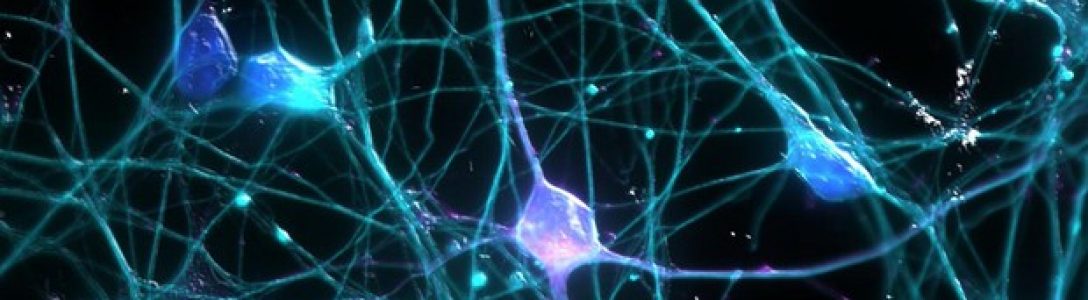

[…] teoria che spieghi la specifica funzione del sonno (per un approfondimento al riguardo, clicca qui), le conseguenze della privazione di sonno e di un’elevata sonnolenza diurna sono note e […]
"Mi piace""Mi piace"